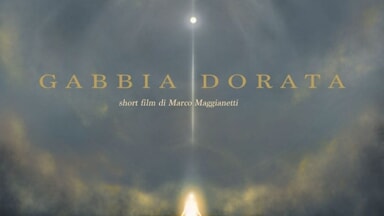Il reato di plagio, previsto dal codice penale italiano fino al 1981, continua a suscitare dibattiti. Alcuni chiedono la sua reintroduzione per contrastare manipolazioni psicologiche e abusi mentali. Tuttavia, esperti e giuristi mettono in guardia: il plagio, così come definito in passato, era una norma troppo vaga e potenzialmente pericolosa per le libertà individuali.
Un reato troppo vago e difficile da applicare
Il reato di plagio puniva chiunque fosse riuscito a “sottomettere la volontà di un’altra persona, annullandone la libertà di autodeterminazione”. A prima vista, l’intento sembrava nobile: difendere chi veniva manipolato psicologicamente fino a perdere ogni autonomia di pensiero.
Ma la realtà era diversa. La legge non chiariva in modo preciso cosa costituisse esattamente plagio e dove finisse la persuasione legittima. La mancanza di confini certi rendeva il reato impraticabile in tribunale: prove inequivocabili di una completa perdita di volontà erano praticamente impossibili da ottenere. La norma si scontrava con principi costituzionali come la libertà personale e la presunzione di innocenza, tanto che la Corte Costituzionale ne aveva più volte sottolineato i limiti.
L’avvocato penalista Marco Rossi spiega:
“Il plagio, come era definito, si fondava su concetti psicologici difficilmente traducibili in prove concrete. In un processo, bisognava dimostrare che la vittima non avesse più alcuna capacità di autodeterminazione, cosa praticamente impossibile. Questo rendeva la norma un’arma spuntata e pericolosa per i diritti civili“.
Perché è stato abolito?
Nel 1981, la legge sul plagio fu ufficialmente abrogata. La decisione fu motivata dal rischio di abusi e dalla difficoltà di garantire un giusto processo. Il rischio di criminalizzare rapporti umani complessi senza basi oggettive era troppo alto. La norma, troppo generica e indeterminata, avrebbe potuto diventare uno strumento di repressione.
Il giudice emerito della Corte di Cassazione, Anna Bianchi, aggiunge:
“La norma sul plagio rischiava di essere utilizzata per reprimere idee e comportamenti ritenuti scomodi. La libertà di pensiero è un diritto fondamentale, e una legge troppo vaga avrebbe potuto comprometterla gravemente“.
Le alternative alla reintroduzione
Oggi, il panorama legislativo offre strumenti più mirati per contrastare forme di abuso psicologico. Lo stalking, il maltrattamento in famiglia, la violenza psicologica sul luogo di lavoro sono già puniti dalla legge con criteri più precisi e prove più facilmente acquisibili.
Un esempio concreto è la recente introduzione del reato di maltrattamenti in famiglia, che ha permesso di intervenire in molti casi di violenza psicologica, anche quando questa non si traduce in violenza fisica.
La psicologa clinica Laura Ferri commenta:
“Le dinamiche di manipolazione sono complesse, ma è importante distinguere tra influenza negativa e vera perdita di volontà. Le leggi attuali, se ben applicate, possono proteggere le vittime senza limitare la libertà personale“.
I rischi di una nuova legge sul plagio
Reintrodurre un reato simile senza una definizione chiara potrebbe aprire la strada ad abusi e strumentalizzazioni, trasformando la legge in uno strumento di controllo sociale o ideologico. La libertà di pensiero e di autodeterminazione, pilastri della nostra democrazia, potrebbero essere messi in pericolo da una norma troppo generica.
Un caso emblematico risale agli anni ’70, quando alcuni gruppi religiosi e politici tentarono di utilizzare il reato di plagio per incriminare avversari e dissidenti, con scarsi risultati ma grande allarme per la libertà personale.
Conclusioni
La storia del reato di plagio insegna che, sebbene sia fondamentale tutelare le persone da manipolazioni e abusi psicologici, la risposta giuridica deve essere precisa, efficace e rispettosa dei diritti fondamentali. La cancellazione del plagio come reato penale è stata una scelta necessaria per salvaguardare la libertà individuale. Oggi, più che mai, serve una legislazione mirata e circoscritta, capace di distinguere tra legittima influenza e abuso, senza sfociare in norme che rischiano di violare i principi democratici.
Martedì intervisteremo la Dott.ssa Raffaella Di Marzio sull’argomento. Laureata in Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze Storico-religiose, ha conseguito il dottorato in Psicologia presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma nel 2016.
Da oltre 30 anni la dottoressa si occupa di ricerca, studio e informazione sul mondo delle religioni e spiritualità minoritarie, diffuso sul nostro territorio e nel mondo. Svolge attività di docenza e formazione permanente nell’ambito della psicologia, della conversione e de- conversione religiosa, della psicologia dei gruppi e della sociologia e della devianza applicata all’uso dello stigma di setta da parte dei media e dei movimenti anti-sette.